ROTARY CLUB, LA STORIA
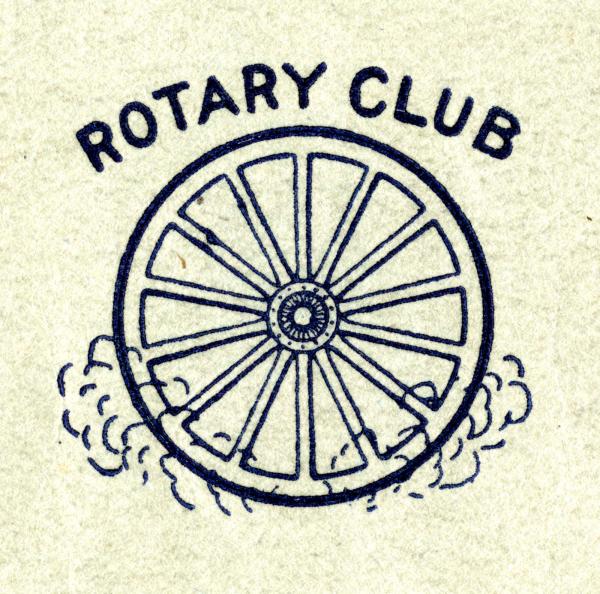
ll Rotary nacque il 23 febbraio 1905, allorquando Paul Harris, allora giovane avvocato di Chicago, si incontrò con tre amici per discutere un’idea che da tempo lo assillava: dar vita ad un club di persone di differenti professioni, organizzando incontri regolari all’insegna dell’amicizia, per trascorrere un po’ di tempo in compagnia e allargare le conoscenze professionali.
Quella sera, a Chicago, assieme a Paul Harris, c’erano Silvestre Schiele, commerciante di carbone, Gustavus Loehr, ingegnere minerario e Hiram Shorey, sarto. Da quella riunione cominciò a realizzarsi l’idea di un club maschile dove ogni socio rappresentava la propria professione. Le riunioni si svolgevano settimanalmente, a turno presso l’ufficio o a casa dei vari soci. Era, questo, un sistema di rotazione che aveva lo scopo di far conoscere a ogni socio l’attività degli altri e che portò poi Harris a chiamare il suo sodalizio: Rotary.
I quattro soci fondatori erano di discendenza nazionale diversa (americana, tedesca, svedese e irlandese) ed appartenevano anche a fedi religiose diverse (protestante, cattolica ed ebraica). Dopo l’ammissione di un quinto socio, il tipografo Harry Ruggles, il gruppo prese ufficialmente il nome di Rotary Club di Chicago. La notizia della nuova organizzazione si diffuse rapidamente e ben presto i soci divennero così numerosi da rendere poco pratiche le riunioni negli uffici dei soci. Nacque così l’usanza di tenere le riunioni settimanali presso ristoranti o alberghi. Nel 1907, due anni dopo la fondazione del club, fu varato il primo progetto in favore della collettività: la costruzione, nei pressi del municipio, di toilettes pubbliche: la prima infrastruttura del genere creata a Chicago.
Tre anni dopo la fondazione del club di Chicago fu creato un secondo club a San Francisco, e l’anno seguente si aggiunsero all’elenco altri tre club. Nel 1910, sparsi in tutti gli Stati Uniti, c’erano 16 club con oltre 1500 soci. L’ideale del servire cominciò a prendere forma da quando Arthur Frederick Sheldon divenne socio del club di Chicago. Egli era fermamente convinto che ogni professione dovesse essere considerata come un mezzo per servire la società, I primi tentativi di Paul Harris di costituire un club fuori dai confini degli Stati Uniti furono coronati dalla fondazione di quello di Winnipeg, in Canada, avvenuta nel 1911. Fu così che il Rotary divenne internazionale.
Arch Klumph, sesto presidente del R.I., fu l’ideatore, nel 1917, della Fondazione Rotary. Più tardi, quello stesso anno, Paul Harris si mise in contatto con il bostoniano Harvey Wheeler, proprietario di un cotonificio in Inghilterra, allo scopo di costituire un club a Londra. Poco dopo, lo stesso Wheeler, con Arthur Frederick Sheldon e E. Sayer Smith, fondò i club di Londra e di Manchester. Nel medesimo tempo - marzo 1911 - Stuart Morrow, un ex rotariano di san Francisco, aveva organizzato un club a Dublino e uno a Belfast Vennero fondati in Scozia i club di Glasgow e di Edimburgo, ed altri in varie località dell’Inghilterra. Una volta varcato l’Atlantico, il Rotary si diffuse rapidamente e. Il primo Rotary Club che venne costituito in un paese non di lingua inglese fu, nel 1916, quello cubano dell’Avana. Il Rotary incominciava quindi a oltrepassare non solo i confini nazionali, ma anche le barriere linguistiche, senza tuttavia acquisire una dimensione veramente mondiale sino agli anni venti, allorché si diffuse per tutta l’Europa continentale e raggiunse l’America meridionale e centrale, l’Africa, l’Australia e l’Asia.
Tale diffusione, attestata dalla universalità del sodalizio, ha provato e prova che i principi su cui esso si basa hanno ancora una vitalità così intensa ed esercitano un richiamo così forte da superare ogni differenza di razza, religione, lingua e nazionalità. li anni venti furono costruttivi, brillanti, ricchi di sfide: il 1926 in particolare fu l’anno memorabile in cui il Rotary Club di Londra diede uno dei maggiori contributi al movimento rotariano. Sydney W. Pascall, misero a punto quello che fu chiamato il progetto “Scopi e obiettivi”. Avevano pensato cioè di incanalare le attività di servizio secondo quattro precisi indirizzi: l’azione interna, l’azione di interesse pubblico, l’azione professionale e l’azione internazionale. Il Rotary International è stato l’antesignano di altre grandi associazioni di servizio, come il Kiwanis International, costituito nel 1917 e l’Optimist International (1919). Analogamente, sul modello rotariano si vennero a creare organizzazioni femminili di servizio quali lo Zonta International, fondato nel 1919.
Il Rotary ha anche preparato il terreno a numerose importanti organizzazioni di statura mondiale, tra cui la International Society for Crippled Children, fondata nel 1922, attualmente ribattezzata con il nome di Rehabilitation International, e l’Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), le cui basi furono poste nel corso di un convegno rotariano svoltosi a Londra nel 1942 con lo scopo di esaminare la costituzione di un vasto sistema di scambi culturali fra nazioni. Ci sono nel mondo più di 1.208.000 rotariani che danno vita a circa 32.554 Club divisi in 530 Distretti presenti in più di 168 Paesi. I suo prestigio, la sua tradizione e il carisma degli uomini che lo compongono e lo guidano ne fanno l’unica associazione non governativa che ha un suo rappresentante al Consiglio delle Nazioni Unite. E tutto nacque in una riunione di quattro amici circa un secolo fa.
La pacifica invasione dell’Europa
Il Rotary, nato a Chicago nel 1905, grazie alla felice intuizione di Paul Harris, si è rapidamente esteso in America e in Europa. Nel 1914 in Gran Bretagna e in Irlanda si contano già 16 club. Dopo la “Grande Guerra”, nel 1920, inizia la pacifica invasione del continente europeo e “l’Associazione Internazionale dei Rotary Club” assume la denominazione definitiva di “Rotary International”.
L'arrivo in Italia
La storia italiana del Rotary è caratterizzata dalla sua lotta per la sopravvivenza contemporaneamente contro le ostilità del Fascismo e contro quelle della Chiesa Cattolica, queste ultime proseguite fino agli anni ’70. Una storia che conosce due fasi storiche riconducibili, una alla prima metà degli anni ’20 precisamente al 1923 fino allo scioglimento dell’Associazione avvenuto nel 1938 e la seconda che inizia con la sua ricostituzione nell’immediato dopoguerra e che dura tutt’oggi.
La nascita del "Rotary Italiano"
Il 19 giugno 1923 un gruppo di imprenditori stranieri ed italiani, sensibili agli ideali rotariani ormai pienamente radicati nel mondo, si dà appuntamento presso il ristorante “Cova” di Milano per la prima riunione del costituendo Rotary Club di Milano. I soci fondatori sono una ventina. L’ideatore del Club è Leo Giulio Culletton, un ingegnere irlandese residente per lavoro a Milano. Il primo Presidente del Club è James Henderson, vice presidente della Cucirini Cantoni Coats, considerato il fondatore del “Rotary Italiano”, il segretario del Club è Culletton. Inizia così la storia del Rotary in Italia
I criteri di ammissione
Un mese dopo il Club ha la sua “Carta” ma la genericità degli indirizzi del Rotary International (R.I.) determinano un contrasto interno ai promotori con conseguenti riflessi sulla vita del Rotary in Italia e sui criteri di ammissione dei nuovi soci. Culletton è dell’idea di creare un Rotary “democratico” aperto a tutti, mentre Henderson vuole un Rotary “aristocratico”, di élite, nel senso della competenza professionale, della moralità ma soprattutto del censo dei soci. Quest’ultima idea prevale nettamente e da quel momento e negli anni a seguire, il Rotary italiano mantiene questo criterio di ammissione secondo cui i soci, oltre che dal punto di vista morale, devono rappresentare le migliori energie esistenti nel campo industriale, commerciale e professionale.
I nuovi club
Al Consiglio Direttivo del Rotary Club di Milano è assegnato il compito di suggerire al Segretario Generale del R.I. le persone più adatte per organizzare gli altri club in Italia. Nel 1924 viene costituito il Club di Trieste e nello stesso anno sono costituiti i Club di Roma, Torino, Napoli, Firenze, Livorno, Venezia, Bergamo, Parma e Cuneo. L’Italia è il primo Paese europeo continentale (3 febbraio 1925) ad ottenere un proprio Distretto (il 46° Distretto del R.I.) l Nei primi mesi del 1925 viene creato il “Consiglio Nazionale dei Club italiani”, non previsto dal R.I. e giustificato dai dirigenti italiani dalla differenza esistente tra i club americani e quelli italiani e dalla necessità di adattare le procedure studiate negli Stati Uniti al diverso sviluppo della vita sociale italiana. In realtà, il motivo principale risiede nell’esigenza di dover compiacere il Governo Fascista e il suo diktat di avere un Rotary nazionale.
Il Rotary e il fascismo
Nel periodo fascista tutte le organizzazioni, non legate al partito, devono confrontarsi con la politica del Governo e ad essa adeguarsi. Tra queste, il Rotary che, a causa della sua natura internazionale e in quanto portatore di valori chiave quali l’amicizia tra gli uomini, la comprensione reciproca e la pace tra i popoli, deve fronteggiare l’aggressivo nazionalismo fascista (Molti nemici molto onore!). Nei primi anni di vita del Rotary Italiano i fascisti non ostacolano l’attività rotariana sebbene sospettosi nei confronti di un’associazione considerata un’emanazione del Rotary americano. Al Re Vittorio Emanuele è offerta la carica di Governatore Onorario del 46° Distretto del R.I. ed i Principi di Casa Savoia e Aosta sono soci onorari di club di diverse città. Sono soci effettivi alti esponenti del fascismo come Arnaldo Mussolini e Galeazzo Ciano. In quel periodo sono Presidenti di club Giovanni Agnelli a Torino, Borletti, Presidente della Rinascente, a Milano, Giuseppe Volpi, Ministro delle Finanze, a Venezia, Gaetano Marzotto, industriale laniero, a Vicenza. Nel 1927 il Club di Milano esprime a Mussolini il desiderio di averlo come socio onorario ma riceve un netto rifiuto. Malgrado il prestigio dei soci che ne fanno parte, il Rotary Italiano per continuare ad operare è costretto a ridurre sempre più i rapporti con il R.I. e ad accettare il controllo fascista. Con il passare del tempo, sorgono all’interno dei club inevitabili contrasti tra chi tenta di conciliare l’internazionalità e la democrazia del R.I. con la politica del Governo Fascista e chi, ossia i soci con la tessera del partito, considera il Rotary un’associazione pacifista al servizio degli interessi americani. Tra queste due posizioni vi sono rotariani che, nel tentativo di mediare, sostengono che si possa essere insieme buoni rotariani e buoni patrioti. La lentezza con cui si sviluppa il Rotary in quegli anni è dovuta principalmente alla decisione dei dirigenti di attuare una politica di cooptazione dei grandi nomi, basandosi, più che sul merito, sulla nascita e sul censo, perché considerata necessaria per riuscire a continuare ad esistere. Così i club italiani assumono sempre più una forte caratteristica elitaria suscitando aspre critiche da parte dei rotariani nord-americani. Il Presidente Internazionale in visita al Club di Milano dichiara di avere l’impressione di “trovarsi non tra fratelli e che la barca del Rotary In Italia è tirata verso un’altra direzione” Nel 1928, il Consiglio Nazionale istituisce addirittura una Commissione Nazionale per le ammissioni (unica al mondo nel Rotary) con il compito di esaminare le candidature proposte dei singoli club che, solo dopo essere state approvate, possono essere sottoposte al giudizio definitivo dei soci. Si tende sempre al numero “uno” in senso assoluto in ogni attività.
L'accusa massonica
Sempre nel 1928, il rapporto del Rotary con il Fascismo conosce una grave crisi. Il giornale “La Tribuna” infatti pubblica l’articolo comparso sul quotidiano polacco “La Gazzetta di Varsavia” che denuncia il Rotary come associazione di origine massonica. Questo equivoco Massoneria – Rotary va avanti, con sempre maggiore insistenza, sulla stampa fascista che considera il Rotary come la Massoneria, una fratellanza di uomini d’affari. A difesa dell’attività rotariana, il Governatore Ginori-Conti in una relazione, fatta pervenire a Mussolini, spiega, in risposta alle critiche giornalistiche, che le attività del Rotary si svolgono tutte alla luce del sole e che i suoi scopi sono agli antipodi degli scopi e dell’attività della Massoneria. Dopo questa presa di posizione da parte dell’alta dirigenza rotariana, la “chiarificazione” del Governatore pubblicata sulla rivista “Rotary” del gennaio 1929 e l’intervento diretto di Omero Ranelletti presso il Direttore de “La Tribuna”, per qualche tempo, la stampa fascista non attacca più il Rotary. Anzi, in un articolo della rivista “Critica Fascista”, Alessandro Pavolini, allora giovane esponente del partito, annuncia che il Governo ha deciso di lasciar vivere il 46° Distretto del R.I. cioè il “Rotary Italiano”.
La Dichiarazione dei Principi del Rotary
A metà del 1929 ha luogo un evento storico per il Rotary International: il V° Congresso Distrettuale di Napoli. In occasione del Congresso viene stilata la “Dichiarazione dei Principi del Rotary” adottata successivamente dal Congresso Internazionale di Dallas dello stesso anno e che diverrà un caposaldo per il R.I., modificando l’Art. 1 del suo Statuto. Con questa Dichiarazione si cerca di chiarire a tutti cosa è il Rotary in modo tale da riuscire ad attenuare il contrasto, sempre latente, tra Rotary e Fascismo. “Il Rotary è un’associazione di cittadini scelti tra gli esponenti più stimati delle singole attività economiche, scientifiche, tecniche, culturali, collegati essenzialmente da un criterio di praticità ed interesse intellettuale che è quello di comunicarsi, in piena amicizia, in occasione delle riunioni settimanali, i risultati delle loro esperienze e del loro sapere. Mentre nella vita moderna, in tutti i campi, si tende alla specializzazione, i periodici incontri tra i soci permettono ad ognuno di conoscere, negli aspetti fondamentali, quelle altre attività che non sarebbe facile conoscere altrimenti, dato l’impegno quotidiano nella propria attività. In questo modo il Rotary vive di uno scambio di conoscenze tra uomini, ciascuno dei quali parla della propria attività o professione con preparazione e competenza” …”da questo scambio di idee si sviluppano opportune iniziative di carattere eminentemente pratico dirette da una parte a migliorare le attività economiche, tecniche, professionali dei soci stessi, dall’altra a promuovere o aiutare opere d’interesse locale e generale, sempre che dette iniziative non rientrino nella competenza dei pubblici poteri”…”Il Rotary non ha alcun carattere politico o religioso e come tale non ha mai inteso né intende formare alcun partito o alcuna setta, né attribuirsi uno speciale codice etico. Potendo far parte del Rotary persone di religioni diverse, esso professa il più assoluto rispetto della fede dei suoi membri”…”In questo pieno rispetto del sentimento religioso e del sentimento nazionale dei suoi membri, il Rotary trova la ragione prima del suo sviluppo in tutto il mondo e la possibilità di contribuire alla migliore convivenza e comprensione tra i popoli”
La difficile convivenza con il fascismo
Negli anni successivi alla Dichiarazione, il Governo fascista decide di placare l’ostilità nei confronti del Rotary Italiano. Servire il Regime fascista deve rimanere comunque lo scopo primario delle attività rotariane. Fintanto che questo principio non è intaccato, il Rotary non rappresenta una significativa preoccupazione. Questa interpretazione del Rotary permette all’associazione di continuare a vivere al costo di uno stretto controllo sulle attività dei singoli club e della approvazione della nomina dei dirigenti. In quegli anni, ad esempio, il Governatore viene eletto, come previsto, al Congresso Distrettuale ma solo dopo l’approvazione di Mussolini. Nelle attività del Distretto e dei club deve essere sempre presente l’impegno verso il Partito Fascista e l’ossequio al suo Capo.
Dalla Germania all'Italia lo scoglimento dei club
Nel 1935, dopo la conquista dell’Etiopia, i contrasti tra i paesi democratici e quelli totalitari si accentuano ripercuotendosi sul clima dei rapporti tra Rotary e Fascismo che con il passare del tempo diventano sempre più tesi e difficili. Nell’estate del 1937, mentre nei Paesi democratici europei i sentimenti rotariani crescono, in Germania il regime nazista scioglie i club rotariani. Nel giugno 1938, dopo i ripetuti rifiuti di udienza con Mussolini, il Governatore Ruggeri-Laderchi si dimette dall’incarico. Al suo successore, Attilio Pozzo, industriale petroliero, è offerta la possibilità di modificare le regole del Rotary Italiano in base alle direttive del Fascismo, anche se in aperto contrasto con i principi del R.I.. L’offerta, naturalmente, non è accettata e il 14 novembre 1938 il Consiglio Nazionale, su imposizione del Governo Fascista, delibera lo scioglimento dei club entro la fine dell’anno. N ell’ultima riunione del prestigioso Club di Roma, il Presidente Omero Ranelletti afferma che non si tratta di “un atto di liquidazione” e si dichiara certo che, fuori dai club, i rotariani italiani sarebbero riusciti a conservare intatto il patrimonio della migliore reciproca conoscenza di cui si erano arricchiti in quindici anni di vita comune: “Il club si scioglie con la coscienza e la fierezza di aver servito, sopra ogni altro pensiero e proposito, gli ideali e i superiori interessi della Patria”. Il R.I. segue le vicissitudini italiane con distacco anglosassone anche se con molta preoccupazione per l’ulteriore perdita di presenza in Europa considerata la precedente chiusura del club tedeschi. Nell’ottobre del 1938, allorché il Partito Fascista decide lo scioglimento del Rotary in Italia, al R.I. non resta che accettare la decisione. I rotariani più ferventi, portano nelle loro abitazioni il materiale usato durante le riunioni: campane, martelli, ruote presenze, verbali, annuari ecc.. A Milano, a Roma ed in altre città, una settimana dopo la chiusura dei club, i rotariani si incontrano clandestinamente in vari ristoranti.
Il Rotary Italiano dopo la caduta del fascismo
Dal 1944 con l’avanzata delle truppe angloamericane i club rotariani si ricostituiscono. Nel maggio del 1944 riapre il Club di Messina, a luglio quello di Palermo e nei mesi successivi quelli di Napoli e Firenze. Bisognerà attendere la fine degli anni ’40, precisamente il 1946 e il 1948 per la ricostituzione dei club di Milano e Roma. La riapertura dei club pone la delicata questione della valutazione dei comportamenti tenuti dai soci durante il periodo fascista. Alcuni optano per l’ammissione esclusiva solamente di coloro che non hanno avuto rapporti diretti con il regime. Altri club invece, decidono l’istituzione di un’apposita commissione incaricata di revisionare l’elenco dei soci.
La democratizzazione del Rotary Italiano
Nel 1946, Achille Bossi, uno dei soci fondatori del Club di Milano e Segretario del Distretto sin dal 1925, dopo i contatti con l’Ufficio Europeo di Zurigo e con il Consiglio Centrale del R.I., viene nominato Commissario Speciale per la ricomposizione del Rotary Italiano. Nello stesso anno, sotto la presidenza di Omero Ranelletti, si tiene a Pallanza il Congresso Nazionale sul tema della “democratizzazione” del Rotary in Italia. Il dibattito sorge dalla necessità di dover conciliare linee di pensiero contrastanti relativamente alla flessibilità dei criteri di ammissione ai club. Alcuni delegati sostengono infatti che, come negli USA, i club debbano essere aperti agli esponenti di tutte le categorie sociali e dunque prediligendo la rappresentatività del Rotary all’esclusività elitaria. Diversa invece la linea di pensiero di chi teme che una tale situazione possa comportare un’eterogeneità tale da creare difficoltà e scontri nella gestione interna dei club. Non riuscendo a giungere ad un accordo che concili i differenti punti di vista, Ranelletti decide di adottare una soluzione che permette di cooptare soci più giovani che, pur di secondo piano, potrebbero in futuro raggiungere posizioni più elevate, ritenendo che, un simile compromesso, non avrebbe privato i club degli esponenti migliori. All’unanimità sono invece adottate alcune decisioni riguardanti l’organizzazione del Distretto. Si conviene di non ricostituire il Consiglio Nazionale e la denominazione di “Rotary Italiano” è sostituita, come negli altri Paesi, dal numero del Distretto del R.I.
L'evoluzione del Rotary in Italia
Il Club di Milano riapre presentandosi con un’immagine diversa rispetto a da quella del passato. Il Club rappresenta ancora l’élite della città non nel senso della ricchezza materiale e del censo ma nel senso della ricchezza morale, culturale ed intellettuale. Ranelletti, alla presenza di De Gasperi, di Vittorio Emanuele Orlando, di numerosi Ministri e Sottosegretari, riapre il Club di Roma nel febbraio 1948. Negli anni ’50 il Rotary in Italia raggiunge un notevole prestigio a livello internazionale e per la prima volta un italiano, Paolo Lang, viene eletto alla carica di Presidente Internazionale per l’anno 1956-57. Nell’anno 1957-58 il Distretto 46° del R.I. viene scisso in quattro Distretti: 184-186-188-190. Col tempo i club italiani acquistano sempre maggiore considerazione presso il R.I. fino ad ottenere nel 1970 l’incarico di organizzare a Roma il Congresso Regionale dei Paesi Europei e Mediterranei. In questa occasione i club romani finanziano la restaurazione e la costruzione della protezione dell’Ara Pacis di Augusto. Questo intervento, simbolo di pace tra i popoli, è accolto con grandi apprezzamenti da parte dell’opinione pubblica internazionale e da autorevoli personalità quali quella del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e di Papa Paolo VI che, il 14 novembre 1970, nell’udienza a tremila rotariani, formula l’augurio che l’avvenimento “possa coincidere con un’era di pace ritrovata tra i Paesi d’Europa e del Mediterraneo”. Nel giugno 1979 si svolge a Roma il 70° Congresso del R.I. a cui partecipano oltre dieci mila rotariani provenienti da tutto il mondo. I partecipanti a questo Congresso vengono salutati dal Presidente della Repubblica e ricevuti dal Papa Giovanni Paolo II. In questa sede è approvato lo storico programma delle 3H (Hunger, Health, Humanity) con il quale sono posti importanti obiettivi volti a garantire un’adeguata alimentazione per i bambini che soffrono la fame nel mondo, l’attenuazione delle sofferenze dei più poveri e la diffusione di un maggior senso di umanità. Il Congresso si conclude con l’impegno dei rotariani ad offrire tutta la oro potenzialità nel tentativo di tradurre in pratica questo programma che, da quel momento, entra definitivamente nell’attività della Fondazione Rotary. Nel 1979 viene avviato un primo progetto 3H nelle Filippine per la vaccinazione antipolio di 6 milioni di bambini in 6 anni. In occasione del 75° anniversario della fondazione del R.I., su iniziativa del Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca, con i fondi raccolti dai Distretti lombardi e veneti, viene donato ai bambini filippini un primo milione di vaccini antipolio. È l’inizio di quello che nel 1988 sarà il programma “Polio Plus” del R.I. che diviene uno dei principali partner della “Global Polio Eradication Initiative” Oggi far parte del Rotary non costituisce uno “status symbol”. I club accolgono soci di tutti i ceti sociali dotati delle migliori qualità morali e professionali, impegnati a rendersi utili al prossimo “al di sopra di ogni interesse personale”. Il numero dei club Rotary in Italia è in continua crescita ed è passato dai 25 club con 1000 soci del 1930 agli 803 club con 42680 soci del 2011. I Distretti italiani nel tempo sono aumentati ed oggi sono 10.
Rotary e la Chiesa Cattolica
La Chiesa Cattolica ha sempre seguito con sospetto l’evolversi del Rotary. Le numerose divergenze risiedono in particolar modo nella mancanza di conoscenza dello spirito rotariano e nell’equivoco della parentela con la massoneria. L’ostilità della Chiesa Cattolica nei confronti del Rotary conosce il suo apice nel biennio del 1928-1929. Incapace di comprendere i principi base dell’associazione quali la disponibilità verso il prossimo e l’ideale del servire, la Chiesa ritiene che il Rotary si fondi su una morale laica ed indipendente e sia dunque completamente indifferente alla religione cristiana.
La stampa cattolica e il 1° Decreto del Sant'Ufficio
Nei Paesi dove il Cattolicesimo è più intransigente (specialmente in Italia, in Spagna e nell’America Latina), il Rotary viene considerato una setta da condannare come la Massoneria ed il Comunismo. Nel 1927 alcuni Vescovi dell’America Latina chiedono alla Santa Sede quale sia la posizione ufficiale della Chiesa nei confronti del Rotary. Il Sant’Ufficio risponde con la promulgazione del 1° Decreto con il quale si proibisce al Clero di iscriversi e frequentare i club rotariani, trascurando il fatto che negli USA sono numerosi i sacerdoti soci dei club Rotary. “L’Osservatore Romano”, nel febbraio 1928, con un articolo dal titolo “Cos’è il Rotary”, riprende il parere espresso da un quotidiano madrileno che sostiene che le origini del Rotary siano di natura massonica. La rivista dei Padri Gesuiti “Civiltà Cattolica” qualche mese dopo, pubblica un articolo nel quale si afferma che: “molti vedono nel Rotary, propagatosi in pochissimi anni in tutto il mondo, un’emanazione massonica, una nuova specie di massoneria a pieno giorno. La filosofia rotariana considera alla stessa stregua tutte le religioni, compresa quella cattolica. Il rotariano, qualunque religione professi, adotta un codice morale che prescinde dai dettami di tutte le religioni positive”.
Il "codice etico rotariano"
Qualche mese dopo, sullo stesso argomento la rivista dei Gesuiti scrive: “È certo che lo spirito del Rotary appare sostanzialmente massonico, basta leggere il suo codice morale per accorgersi come esso si fonda su un concetto laico della vita morale, lontano dal concetto cristiano, che si traduce in un vero utilitarismo individuale, mascherato da vaghe idee umanitarie” e vengono riportati alcuni articoli del “codice etico rotariano” ( art. XVI del Regolamento del R.I. allora in vigore). - Devo essere un uomo d’affari ambizioso di riuscire ma soprattutto un uomo onesto il quale non aspira ad alcun guadagno che non sia fondato nella massima giustizia e moralità. Devo esser persuaso che lo scambio delle merci… deve essere legittimo e morale, in modo che tutti coloro che sono interessati nello scambio vi trovino il loro vantaggio. - Non è legittimo né lecito approfittare a proprio vantaggio di certe occasioni di dubbia moralità. - Mai la società sarà unita più strettamente come quando a tutti gli uomini sarà data l’opportunità di usufruire in uguale misura delle ricchezze naturali della terra. Per i Gesuiti il “codice etico rotariano” ha una stretta parentela con il codice massonico, per il quale bisogna sostituire a tutte le religioni positive l’unica vera religione che è quella dell’umanità e, alla morale fondata sulla religione, la morale dell’uguaglianza e della fraternità massonica. Per i Gesuiti nei documenti rotariani è evidente l’assenza di Dio e la pretesa di proporre una nuova morale al di fuori di ogni religione. Per loro, tra la concezione di Paul Harris e quella di Cristo, c’è un dissidio profondo ed inconciliabile. Questa campagna giornalistica de “L’Osservatore Romano” e di “Civiltà Cattolica”, crea una grave inquietudine ed incertezza nei rotariani cattolici. Per questo, il Governatore Ginori Conti nell’assumere la presidenza del Rotary Italiano, cerca di chiarire sulla rivista “Rotary” del 28 luglio 1928, che gli ipotizzati legami tra Rotary e Massoneria non sono giustificati dai fatti e sono in contrasto con l’appartenenza al R.I. di moltissimi prelati cattolici. Precisa che tutte le manifestazioni ufficiali dei rotariani non contengono nulla che non sia compatibile con la loro coscienza di cattolici. Nel mese successivo la rivista “Rotary” pubblica una dichiarazione del Presidente Internazionale J.B.Satton “Quale Presidente del R.I. e quale cattolico, impegno la mia parola d’onore che il Rotary non ha mai avuto alcun rapporto con la Massoneria in qualsiasi forma; affermo inoltre che il Rotary non ha mai assunto alcun atteggiamento, né compiuto mai alcun atto non amichevole verso il cattolicesimo; è significativo che migliaia di cattolici laici e sacerdoti non hanno ritenuto l’appartenenza al Rotary incompatibile con la loro appartenenza alla Chiesa”. Tramite il Governatore del Rotary Italiano, Omero Ranelletti riesce a portare il Presidente Satton in Italia facendolo incontrare con Padre Enrico Rosa, Direttore della rivista “Civiltà Cattolica”. Nei numerosi colloqui avuti con Padre Rosa ed altri Prelati, il Presidente Satton sostiene l’assoluta indipendenza del Rotary dalla Massoneria e s’impegna a sottoporre al R.I. la proposta di eliminare dal Regolamento del R. I. il “codice etico rotariano” che tanti dubbi e timori ha suscitato nella Chiesa che lo considera come un travestimento della morale laica massonica. L’azione del Presidente Satton si svolge durante il Congresso Internazionale di Dallas e il Consiglio Direttivo del R.I. nella seduta dell’aprile del 1929 dispone che il cosiddetto “codice etico” non si debba più “usare o stampare in qualsiasi foglio rotariano” e che siano prese adeguate misure” per sopprimere la pubblicazione dello stesso in ogni parte del mondo”.
Le nuove diffidenze della Chiesa Cattolica
Tutte queste dichiarazioni da parte della autorità rotariane non persuadono però la stampa cattolica. Nel 1929, “L’Osservatore Romano” pubblica la Pastorale del Vescovo di Segura, Primate di Spagna nella quale consiglia ai fedeli di astenersi dal far parte del Rotary che professa un laicismo assoluto con la pretesa di moralizzare gli individui e la società. La conseguenza di questa presa di posizione da parte dell’episcopato spagnolo è la chiusura del club rotariani del Paese. Ranelletti, in quanto cattolico praticante e rotariano convinto, rimane particolarmente amareggiato per le nuove critiche della Chiesa. Il giorno dopo la pubblicazione dell’articolo, ottiene un colloquio con Padre Rosa. L’incontro permette a Ranelletti di precisare al direttore di “Civiltà Cattolica” il vero significato del Rotary vale a dire un’associazione di uomini senza discriminazione di razza, colore, di nazionalità, di ideali politici e religiosi, uniti dal comune intento di servire gli interessi superiori della comunità in nome della pace. Precisa inoltre che “il Rotary non è la negazione di ogni religione; né un laico indifferentismo religioso; al contrario la completa 9 autonomia del Rotary da ogni religione è volta a garantire il rispetto dei sentimenti religiosi di ogni socio”. Altri colloqui con Padre Rosa ottengono alla fine, lo scopo di chiarire l’equivoco e di confermare il principio rotariano del rispetto di tutte le religioni. Il 9 maggio del 1929, come già detto, si svolge a Napoli il V° Congresso del Distretto Italia, nel quale viene approvato all’unanimità la proposta di modificare l’ Art. 1° dello Statuto del R.I. nel senso di mettere in evidenza che il Rotary non intende formare alcun partito o alcuna setta né intende attribuirsi un particolare codice etico. Questa modifica viene approvata dal Congresso Internazionale di quell’anno a Dallas. Ciò pone, finalmente, fine a tutte le polemiche in corso e, dopo il 1929, per quasi un ventennio non ci saranno ulteriori scontri né sulla stampa cattolica né su quella laica. Sulla crisi dei rapporti con la Chiesa e sulle conseguenti modificazioni nell’ordinamento del R.I. si può affermare che questa ha posto in evidenza soprattutto il contrasto sul “codice etico” e, in misura minore, sul pericolo che il Rotary sia influenzato dalla Massoneria. Domina la scena, la rinuncia del R.I. al “codice”. Il Consiglio Centrale del R.I. nella riunione del 1951-52 stabilisce di cessare la pubblicazione del “codice”. Anche il Consiglio di Legislazione del 1977 torna sul “codice” e se ne discute in altre riunioni degli organi direttivi centrali del R.I. ma non vengono prese decisioni risolutive. È solo nel 1980 che il Consiglio di Legislazione risolve definitivamente il problema con l’abolizione dell’Art. XVI del Regolamento del R.I. Nel 1940 si riaccendono delle polemiche a causa degli atteggiamenti contrastanti di alcuni Vescovi, sia in Europa che nell’America Latina. Infatti, mentre alcuni di loro proibiscono anche ai laici di iscriversi al Rotary, altri, benedicono le attività benefiche dei club Rotary locali o elogiano l’attività dei rotariani. La Santa Sede, nel tentativo di evitare questi opposti comportamenti dei Vescovi, chiede ai Nunzi e ai Delegati Apostolici di esprimere il loro parere al riguardo. La maggior parte degli Alti Prelati si conferma ancora contraria al Rotary a causa delle accuse di indifferentismo religioso. Solo una minoranza ritiene che il Rotary, essendo rispettoso di tutte la religioni, non può essere né antireligioso né anticattolico e deve essere considerato, invece, come un’associazione di beneficenza, non nociva alla religione, mirante ai buoni rapporti tra i soci, senza la pretesa di orientare la loro vita privata e tanto meno quella spirituale. Di fronte a queste opposte posizioni la Chiesa decide di adottare un atteggiamento prudente ma vigilante.
Il 2° Decreto del Sant'Ufficio
Nel gennaio del 1948, il Pro Segretario di Stato, Monsignor Giovanni Battista Montini, comunica al nuovo Direttore di “Civiltà Cattolica”, Padre Giacomo Martegani, succeduto a Padre Rosa, il desiderio di Papa Pio XII di rivedere la “questione Rotary” e chiede di esaminare di persona tutta la documentazione in modo da poter approfondire lo studio del rapporto Rotary-Chiesa Cattolica. L’11 gennaio 1951, “L’Osservatore Romano” pubblica un secondo Decreto del Sant’Ufficio che vieta ai sacerdoti di aderire al Rotary e di presenziare alle riunioni dei club ed esorta i laici a sospettare delle associazioni che cercano di sottrarsi alla legittima vigilanza della Chiesa. Ranelletti, presidente del Club romano, sorpreso e incredulo, si mobilita nuovamente. Forte dell’esperienza e del comportamento tenuto nella soluzione del precedente contrasto, incontra Padre Martegani al quale illustra i lunghi colloqui del 1929 con il suo predecessore, offrendogli tutta la documentazione chiarificatrice in suo possesso. L’azione discreta di Padre Martegani non tarda a dare buoni risultati. Due settimane dopo “L’Osservatore Romano” pubblica l’articolo “A proposito del Rotary Club” che rappresenta un momento fondamentale nella storia del rapporto Rotary-Chiesa Cattolica. Il 2° Decreto non viene modificato ma il risultato è egualmente notevole per l’autorevolezza dell’interpretazione. Per i Sacerdoti viene confermato “illeceità” dell’adesione al Rotary ma è concessa loro la partecipazione a manifestazioni rotariane. Per i laici l’adesione viene consentita o meno secondo il rispetto da parte dei club verso i principi della Chiesa, attribuendo la vigilanza alla “chiaroveggenza” dei Vescovi.
La grande svolta della Chiesa
Nella seconda metà degli anni ’50 i rapporti Rotary-Chiesa Cattolica sono caratterizzati da un alleggerimento della tensione da entrambi le parti. I sospetti e le diffidenze cominciano a cadere e a lasciare posto al reciproco rispetto. Ad aprire questo periodo di serenità concorre la presenza dell’Arcivescovo Montini alla riunione rotariana del Club di Milano del 13 novembre 1957. La visita è seguita attentamente negli ambienti rotariani dato che proprio Montini, come Pro Segretario di Stato di Papa Pio XII, è stato al centro della presa di posizione delle Autorità Vaticane contro il Rotary e del 2° Decreto del Sant’Ufficio. Quell’incontro, ancora oggi, viene definito storico. Ranelletti nei suoi appunti riferisce la parte essenziale del testo del discorso di Montini: ”Vi ringrazio, signori rotariani, per questa manifestazione d’omaggio e di plauso che mi rivolgete ma debbo con lealtà dichiararvi che, in passato, io ebbi molte riserve sul Rotary, frutto d’ignoranza ed errore, ma ora mi limito a dire che sono molto onorato e molto contento di essere questa sera in mezzo a voi”. Il 20 aprile 1959 (per la prima volta) un Presidente Internazionale viene ricevuto in Vaticano dal Papa Giovanni XXIII. Assieme al Presidente C. Randal, con la moglie, partecipa all’udienza il Past P.I. Lang, i quattro Governatori in carica e Omero Ranelletti. Nei suoi appunti quest’ultimo scrive: “… il Rotary dunque agli occhi della Chiesa non è più il demone da condannare e da tenere lontano”. Tra il 1962 e il 1965, Ranelletti, scrive “il vento vivificatore del Concilio Vaticano II, contribuisce in modo determinante a spazzare via tutti gli equivoci e le inquietudini sul Rotary”. Nel 1965 Montini, ormai Papa Paolo VI, riceve in udienza una delegazione di rotariani dei quattro Distretti italiani e tiene un discorso sugli scopi e sull’attività del Rotary da autentico rotariano. Negli anni ‘70 cadono definitivamente le perplessità della gerarchia cattolica e inizia l’attuale periodo di serenità e fiducia reciproca. Il 10 giugno 1970, in occasione del 70° Congresso Internazionale, Ranelletti, ormai ultranovantenne, vede realizzato il suo sogno: settemila rotariani, di vari Paesi e di diverse religioni, assistono in San Pietro ad una Messa celebrata da venti sacerdoti rotariani di vari nazionalità intorno al Papa, il quale così conclude la sua omelia: “Possa il vostro generoso servizio rendere onore ai vostri rispettivi paesi e tradursi nella gioia della vostra vita quotidiana. Voglia il Signore sostenere il R.I. nella nobile causa di servire l’umanità, l’umanità nel bisogno”. Il 14 giugno 1970 più di tremila rotariani, provenienti da tutta l’Europa, dall’Africa e dai Paesi Mediterranei assieme alle più alte autorità rotariane sono ricevuti dal Papa Paolo VI. In quella occasione il Papa in un discorso memorabile si compiace per le molteplici attività del Rotary e per l’impegno, altamente meritorio, nella comprensione e nella solidarietà tra i popoli. Nel 1981 Giovanni Paolo II riceve dalla mani del Presidente Internazionale le insegne di Paul Harris Fellow e, l’anno successivo, il Rotary Internazionale gli conferisce il Premio Rotary per la Comprensione Internazionale e la Pace. Nel 1984 Il Papa riceve quattromila rotariani convenuti a Roma per l’anno Santo e nel 1989 incontra i rotariani del Distretto 2080 in udienza speciale in occasione del Congresso Distrettuale. Il 13 marzo del 2000, Papa Giovanni Paolo II benedice sedicimila rotariani convenuti a Roma da tutti i Distretti italiani per il grande Giubileo. Oggi cancellati tutti i contrasti, i religiosi possono diventare rotariani e anche Presidenti di Club Rotary. Nell’anno rotariano 82-83 un gesuita, Padre Federico Weber, diventa Governatore del Distretto 211. 11 Molti sono i Prelati che attualmente fanno parte di club del Distretto 2080 sia come soci effettivi che come soci onorari. questo criterio di ammissione secondo cui i soci, oltre che dal punto di vista morale, devono rappresentare le migliori energie esistenti nel campo industriale, commerciale e professionale.
I nuovi Club
Per quanto concerne la creazione dei nuovi club, al Consiglio Direttivo del Rotary Club di Milano è assegnato il compito di suggerire al Segretario Generale del R.I. le persone più adatte per organizzare gli altri club in Italia. Nel 1924 viene costituito il Club di Trieste e nello stesso anno sono costituiti i Club di Roma, Torino, Napoli, Firenze, Livorno, Venezia, Bergamo, Parma e Cuneo. L’Italia è il primo Paese europeo continentale ad ottenere un proprio Distretto (il 46° Distretto del R.I.) la cui creazione avviene il 3 febbraio 1925. Henderson è il Governatore e Achille Bossi il Segretario Distrettuale. Nei primi mesi del 1925 viene creato il “Consiglio Nazionale dei Club italiani”, non previsto dal R.I. e giustificato dai dirigenti italiani dalla differenza esistente tra i club americani e quelli italiani e dalla necessità di adattare le procedure studiate negli Stati Uniti al diverso sviluppo della vita sociale italiana. In realtà, il motivo principale risiede nell’esigenza di dover compiacere il Governo Fascista e il suo diktat di avere un Rotary nazionale.
